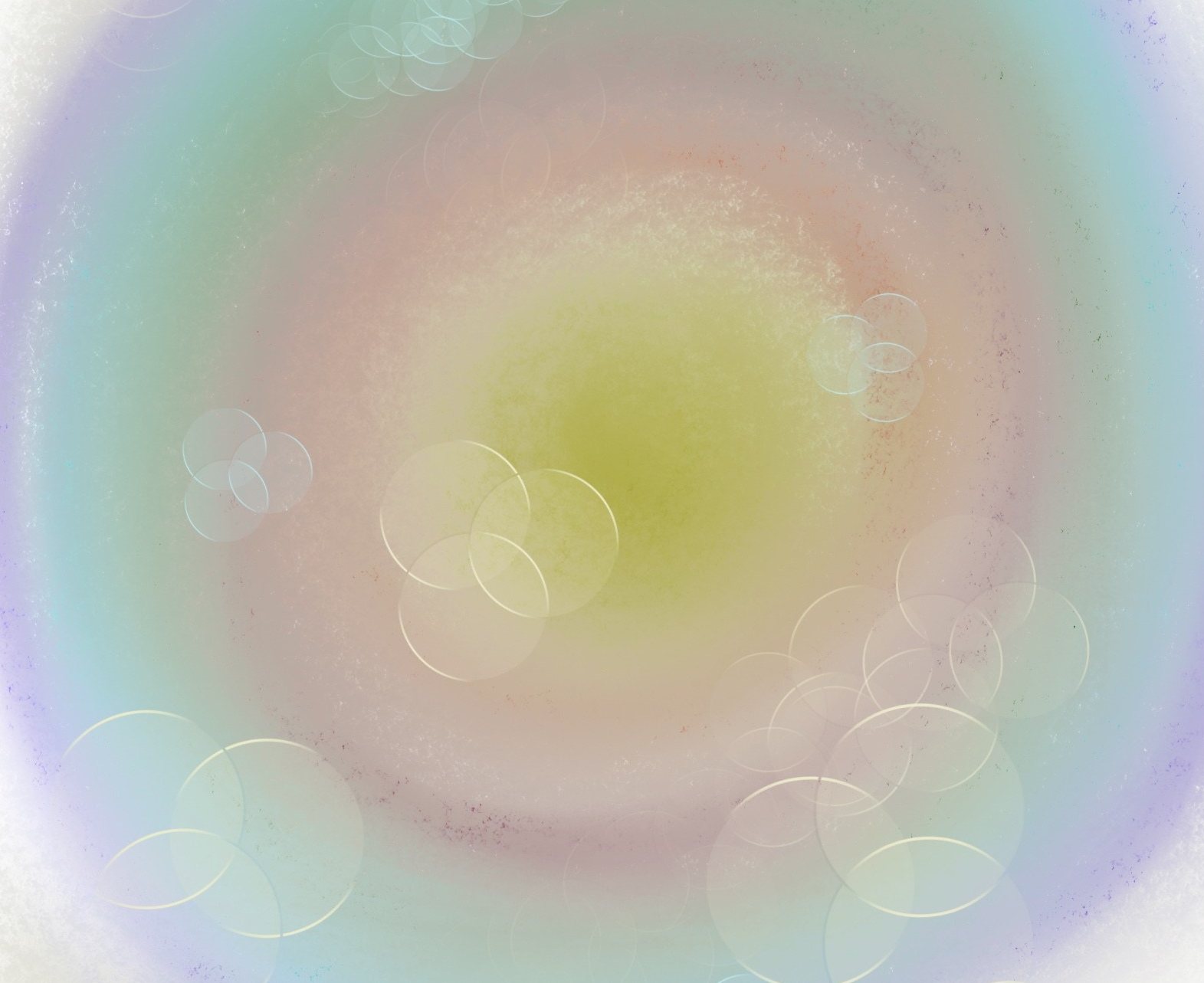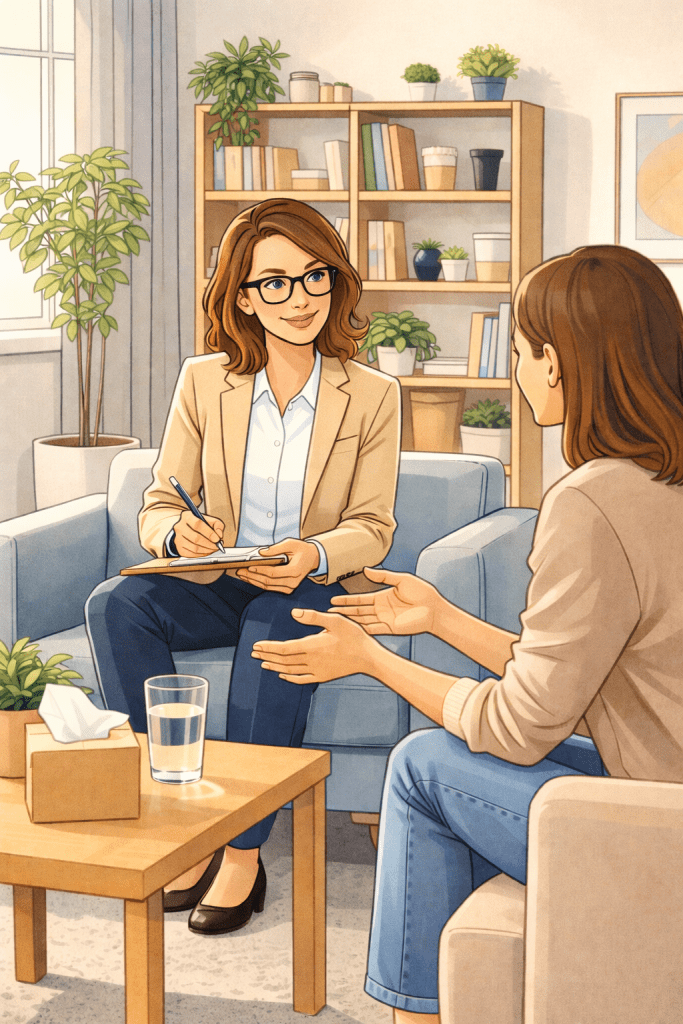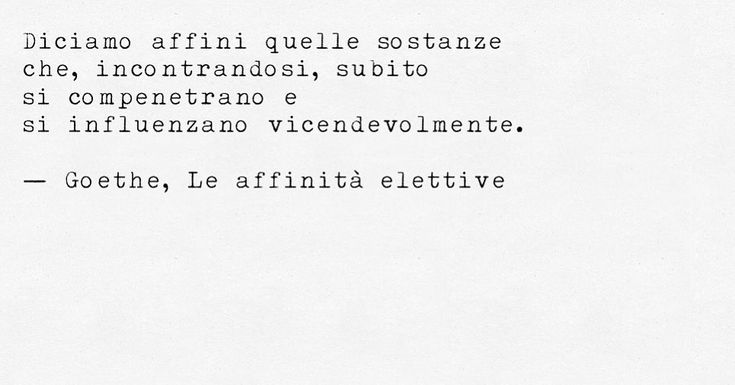Quando un fatto di cronaca eclatante ci scuote la coscienza, come ad esempio un agito violento perpetrato da un ragazzo ai danni di cose o peggio ancora di persone, siamo portati ad interrogarci alla ricerca di comprensione, di colpevoli, di chiarimenti. Questa ricerca di colpevoli, di cure magiche ed immediate sortisce un effetto rassicuratorio, ma solo apparente e limitato a durare poco nel tempo.
La comprensione deve partire dall’analisi delle prime istituzioni di socializzazione, famiglia, scuola, e società stessa. Si tratta di agiti violenti, mal pensati, frutto dell’incapacità di tollerare le frustrazioni e frenare gli impulsi distruttivi. Si può notare come nelle famiglie, così come nell’approccio educativo-scolastico, vi sia una tendenza alla riduzione della possibilità di permettere ai ragazzi di sperimentare la frustrazione e trovare risorse interne necessarie al suo superamento.

I genitori che, per paura che i loro figli possano “soffrire”, sono disposti a dare tutto e subito, senza permettere che nei ragazzi nasca il desiderio. Il desiderio è quel magico modo di pensare a qualcosa che fa nascere all’interno di chi lo sperimenta la ricerca degli strumenti interni che gli permettano di appagare tale bisogno. I genitori vogliono il bene dei loro figli, ma spesso sono loro stessi a fargli del male nel tentativo di amarli. Non permettere ad un figlio di sperimentarsi, di fallire e di rialzarsi equivale al passargli un messaggio costante di non valore. Non essere in grado di reggere le frustrazioni che quotidianamente la vita ci dà, imparando a farlo con piccoli passi nel processo di crescita, innesca un meccanismo che porta a depressione e ad esclusione sociale, “se non mi metto in relazione con gli altri non devo in realtà fare fatica, non mi devo confrontare e non corro rischi, così mi isolo o mi relaziono solo con chi non genera conflitto in me, con chi ad esempio sperimenta la mia stessa rabbia, e la agisce in comportamenti distruttivi”.

Un altro aspetto non meno importante, che spesso viene a cadere nei meccanismi di ragionamento tipici dei bambini e degli adolescenti, è l’incapacità di prevedere e mentalizzare in maniera reale quali siano le conseguenze delle azioni, assorbiti da un mondo che da un lato è fatto di fasulle identità gestite sui Social e dall’altro, dall’eccesso di tutela da parte della società. I nostri ragazzi attraversati da impulsi distruttivi non sono in grado di mettere in atto meccanismi che ne inibiscano gli effetti grazie alla paura delle conseguenze. Non diventano in grado di prevedere e vedere realmente e chiaramente quali sono le conseguenze di certe azioni perché non ne hanno mai sperimentate. Nel giro di pochi anni, con l’influenza della invasione massiccia dei mass media nella vita quotidiana, sono venuti a decadere tutta una serie di valori etici e morali, generando una sorta di smarrimento di riferimenti di figure importanti per indirizzare i comportamenti. Un esempio banale sul quale mi è capitato di riflettere nei giorni scorsi (al quale lascio al lettore quali possano essere le ipotesi evolutive nella società moderna), è questo: “ricordo con affetto di quando la mia maestra delle elementari mi raccontava di questa figura “mitologica”, che era il “Presidente della Repubblica”, all’epoca Cossiga e prima di lui Pertini, e con quale reverenza e rispetto si toccassero semplici discorsi, adatti ad una bambina delle scuole elementari, e di come un clima di rispetto e reverenza si diffondesse. Paragono questo ricordo alla miriade di vignette di dubbia satira e gusto, legate ad offese anche sul piano personale, che quotidianamente ci colpiscono sui Social, in TV, sui giornali, e di come sia diventato “normale” per i più giovani non discriminare figure a cui porre rispetto a prescindere dalle idee o dall’orientamento politico.”
Da qui la domanda, “quanto può valere a questo punto una maestra, un professore, un genitore?“.
Ridare il giusto valore alle cose, potrebbe essere una chiave che vada in una direzione di vero benessere. Il genitore dovrebbe fare il genitore, insegnare una strada, essere un modello, non sostituirsi ai figli, punirli quando necessario, mettere dei paletti, non vivere sotto il costante ricatto emotivo del “cerca in tutti i modi di far si che io non soffra”. Le istituzioni scolastiche non dovrebbero aver paura di mettere alla prova i ragazzi e giudicarli per l’impegno e la perseveranza messa a raggiungere i loro obiettivi e vivere sotto il costante ricatto del: “cerca in tutti i modi di far si che io non soffra”. Proviamo a fidarci noi adulti un po’ di più dei nostri ragazzi e permettiamogli di sperimentarsi, di fallire, di rialzarsi. Permettiamogli di diventare grandi soffrendo, amiamoli veramente.